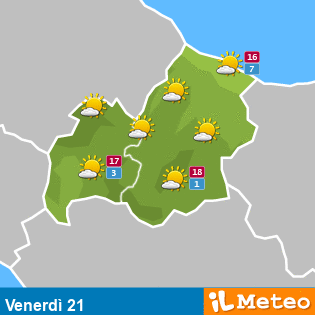Un incontro di quelli che ti migliorano la vita e che ti aiutano a capire che non ci sono differenze tra esseri umani, ma solo esseri umani con esperienze differenti. È questa la sensazione che si prova davanti a una persona come Mamadi Sawo, brillante e coraggioso 29enne originario del Gambia. Mamadi è un rifugiato politico. Nel suo Paese era un giornalista. Ha una laurea in Scienze politiche e parla 11 lingue. Ma il suo lavoro, frutto di impegno e sacrifici, rischiava di trasformarsi in una condanna a morte. Ha deciso così di dare una svolta alla sua vita. Tanti, troppi gli ostacoli che ha dovuto affrontare: il distacco dalla famiglia, la galera, le torture e quella lunga traversata verso una vita migliore. Oggi Mamadi è una persona nuova o forse è lo stesso, solo che qui, ora, è libero di esprimersi e di intravedere uno spiraglio per il futuro. Attualmente lavora come mediatore presso l’associazione “Dalla parte degli ultimi” di Campobasso, è interprete nella Commissione Immigrazione della Prefettura, volontario della Caritas, ha collaborato con la Polizia in veste di interprete, effettua colloqui con i detenuti in carcere ed è spesso ospite nelle scuole per raccontare ai bambini la sua esperienza.
Da quanti anni sei in Italia?
«Cinque».
In Gambia di cosa ti occupavi?
«Ero laureato e facevo il reporter. Ma lì la libertà di espressione è quasi pari a zero e tanti diritti umani, anche quelli più elementari, che diamo per scontato, non vengono rispettati. È proprio a causa del mio lavoro che sono stato costretto ad andare via. Inizialmente ho deciso di spostarmi in Senegal dove sono rimasto per un po’».
Hai dunque ricevuto minacce di morte, la tua vita era in pericolo?
«Prima di lasciare il Gambia sono stato arrestato e torturato. Ma non me la sento di ripercorrere quei momenti. Voglio lasciarmeli alle spalle, perdonami».
Torniamo in Senegal. Come ti sei trovato lì?
«Non avevo ancora in mente l’Europa. Ho deciso di rimanere lì perché penso, da cittadino, che se c’è un problema nel mio Paese ho il dovere di restare e contribuire, anche se in minima parte, a risolverlo  piuttosto che scappare o aspettare che altri lo facciano al posto mio. Ma lì non ero al sicuro. I ribelli in Senegal che fuggono e raggiungono la frontiera rischiano la vita. Non mi sentivo al sicuro e dunque mi sono spostato di nuovo, questa volta in Mali. Mi ha aiutato molto conoscere le lingue. Ogni volta che ci fermava la polizia in gruppo solo uno di noi aveva la possibilità di fungere da portavoce. Molte volte in questo modo sono riuscito a tirare fuori dai guai sia me sia tante altre persone. Ho vissuto tante esperienze nella mia vita. Se vedo qualcuno in difficoltà metto da parte i miei bisogni e cerco di fare di tutto per aiutare gli altri. In Mali sono rimasto solo due settimane, il tempo di guadagnare qualche soldo per poi riprendere il viaggio. Ero completamente solo. In Gambia ho lasciato i miei genitori e i miei fratelli ma non potevo avere contatti con loro perché sarei stato intercettato e avrei messo in pericolo le loro vite. Siccome fuggire era stata una mia decisione, non volevo si ripercuotesse sui miei affetti».
piuttosto che scappare o aspettare che altri lo facciano al posto mio. Ma lì non ero al sicuro. I ribelli in Senegal che fuggono e raggiungono la frontiera rischiano la vita. Non mi sentivo al sicuro e dunque mi sono spostato di nuovo, questa volta in Mali. Mi ha aiutato molto conoscere le lingue. Ogni volta che ci fermava la polizia in gruppo solo uno di noi aveva la possibilità di fungere da portavoce. Molte volte in questo modo sono riuscito a tirare fuori dai guai sia me sia tante altre persone. Ho vissuto tante esperienze nella mia vita. Se vedo qualcuno in difficoltà metto da parte i miei bisogni e cerco di fare di tutto per aiutare gli altri. In Mali sono rimasto solo due settimane, il tempo di guadagnare qualche soldo per poi riprendere il viaggio. Ero completamente solo. In Gambia ho lasciato i miei genitori e i miei fratelli ma non potevo avere contatti con loro perché sarei stato intercettato e avrei messo in pericolo le loro vite. Siccome fuggire era stata una mia decisione, non volevo si ripercuotesse sui miei affetti».
Quanto tempo sei rimasto dunque in Mali?
«In Mali non c’erano le condizioni adatte per sopravvivere. Il clima lì è molto secco. Nel mio Paese molte persone vivono di agricoltura e vanno avanti grazie al raccolto. Lì non potevo farlo. E così mi sono rimesso in viaggio».
Questa volta in Niger, giusto?
«Sì. In Niger sono crollato. Ho pianto molto. Ho ripensato alla mia vita in Gambia e ai sacrifici che i miei genitori hanno fatto per mandarmi a scuola…».
Mamadi è visibilmente commosso. Fa una lunga pausa. Un sospiro. I suoi occhi si riempiono di lacrime. I genitori non ci sono più e il loro ricordo è come una freccia al cuore. Dopo un po’ spiega.
«Ero molto abbattuto. Mi chiedevo come avessi fatto ad arrivare a quel punto. Poi mi sono ‘perdonato’. Ho pensato che non ero l’artefice del male che mi circondava, non meritavo tutto questo. Altri mi avevano messo in quelle condizioni.
Sono rimasto per poco tempo. Ho avviato un piccolo business di compra-vendita per tirare avanti. Una volta raggiunta la somma necessaria mi sono spostato di nuovo. L’ultima tappa è stata la Libia».
Cosa hai trovato in Libia?
«Appena arrivato sono stato arrestato. Anche lì la conoscenza delle lingue è stata la mia fortuna.
Sono uscito di prigione e sono rimasto per 2 anni.
Poi, il 2 gennaio 2014, durante la guerra civile, mi sono imbarcato con altre persone per raggiungere l’Italia.
Dopo due giorni e due notti di viaggio siamo arrivati a Pozzallo dove siamo rimasti 5 mesi. Ci hanno spostato a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo altri 4 mesi ho avuto il colloquio in Commissione e ho ottenuto il permesso come rifugiato politico».
E poi il Molise.
«Sì, al convento di Ripalimosani».
Parliamo della situazione che si respira in Italia. Perché secondo te c’è questo forte senso di intolleranza nei confronti dei migranti?
«Penso che dietro ci siano tanti motivi ma ciò che prevale sia soprattutto la paura verso il ‘diverso’ e un forte senso di superiorità. Molte persone non hanno neanche voglia di conoscere la realtà che li circonda. Ma principalmente è la paura che crea razzismo. Anche tra italiani esiste. Tra uomo e donna, ricco e povero e in tante altre forme. Ma la paura più radicata riguarda il colore della pelle. A Pozzallo una donna mi disse che da piccola, quando faceva qualcosa di sbagliato, i genitori le dicevano di comportarsi bene altrimenti l’uomo nero l’avrebbe portata via. Ecco, già così credo che si pianti il primo seme della paura.
Anche nei film, se ci fai caso, il personaggio cattivo di turno lo interpreta quasi sempre una persona di colore. Sembra poco ma tanto basta a costruire un’immagine sbagliata nei nostri confronti».
Cosa dici a chi vi etichetta come persone che non fanno nulla tutto il giorno, vivono a spese dello Stato e girano sempre con il cellulare in mano?
«Dico che non c’è niente di male ad usare un cellulare. Ciò che non si sa è che molti, quasi tutti, lo utilizzano per restare connessi con il resto del mondo, per informarsi su ciò che accade nel proprio Paese e, soprattutto, per restare in contatto con la famiglia.
Voi quando fate un viaggio poi tornate a casa. Ma il nostro viaggio purtroppo non è una vacanza. Un’altra cosa importante da capire è che non tutti i migranti sono poveri. Non tutte le persone che scappano dalla guerra sono ingenti. Qui si vive con un contributo di 2,50 euro al giorno. Molti mettono da parte quei soldi per comprare il modello di cellulare migliore sul mercato per connettersi al meglio con ciò che li circonda. Ma non è un buon motivo per odiare una persona».
E a chi spaccia o delinque cosa diresti?
«Direi che anche le dita di una mano sono diverse».
Cioè?
«Cioè non tutti gli africani, così come non tutti gli italiani, sono perfetti o fanno sempre del bene.
Sono assolutamente contro ogni forma di illegalità. Queste cose non sono permesse neanche da noi. Ma se hai un problema nel tuo Paese non devi rappresentare tu un problema in un altro».
Molti migranti passano la giornata a chiedere l’elemosina o a rovistare nell’immondizia.
«Sì, ed è una cosa che non condivido. Una volta ho provato a parlare con un ragazzo nigeriano davanti ad un supermercato. Si è arrabbiato tantissimo. Allora sono entrato e ho fatto la spesa anche per lui. Il giorno dopo sono tornato. Sono riuscito a convincerlo a prendere un caffè insieme e gli ho chiesto perché si era infuriato il giorno precedente. Mi ha detto che stava lavorando. Gli ho spiegato che quello non si può definire un lavoro. Lui si è aperto e mi ha raccontato che deve dei soldi agli strozzini che hanno finanziato il suo viaggio. L’Europa non è come la immaginava. Pensava che una volta qui avrebbe trovato lavoro. Se non restituisce la somma pattuita mette a rischio anche la sua famiglia. Come vedi non bisogna mai fermarsi all’apparenza. Ho provato a spiegargli che così non può andare avanti. Che se qualcuno lo considera inferiore e poi lo vede chiedere l’elemosina conferma solo la sua tesi insultando lui, la sua famiglia e il suo Paese.
Quando vedo queste cose ci sto davvero male. Anche con i ragazzi che rovistano nell’immondizia cerco sempre il dialogo ma spesso devi saperli prendere altrimenti rischi solo di peggiorare la situazione. Devi essere davvero motivato per cambiare le cose».
Pensi di tornare un giorno nel tuo Paese?
«Come dicevo prima, non penso solo alla mia vita. Cerco sempre di migliorare la mia situazione per poi mettermi a disposizione degli altri. Qui sto crescendo molto e spero un giorno di riuscire a dare una mano a tante persone. Soprattutto ai miei fratelli africani».
Qual è il ricordo più bello che hai da quando sei qui?
«Senza dubbio gli incontri nelle scuole. In particolare in quella di Petrella. Dopo il mio intervento i bambini mi regalarono un quadro fatto da loro con l’immagine di una barca in mezzo al mare. A fine giornata mi hanno invitato poi a mangiare una pizza tutti insieme. È un ricordo che mi porterò sempre nel cuore e che non dimenticherò mai».
Qual è il tuo sogno nel cassetto.
«Vincere un giorno il premio Nobel per la pace».
Ah una robetta proprio!
(Ride di gusto) «Eh già!».
Pensi che oggi il Molise sia la tua vera casa?
«Assolutamente sì. Vorrei costruire qui il resto della mia vita. In Gambia, a parte due fratelli e una sorella con i quali mi sento quasi quotidianamente, non ho più niente e tutto quello che ho vissuto vorrei lasciarmelo alle spalle. Sono qui ormai da tre anni. Ho un lavoro, amici, una casa in affitto. Mi trovo bene e vedo finalmente un futuro».
Bene, allora ci salutiamo. Secondo te aver raccontato la tua storia è servito a far capire che l’integrazione è possibile?
«Secondo me sì. Vorrei ringraziarvi per avermi ascoltato. È dalle piccole cose, anche da un’intervista, che si possono risolvere i grandi problemi nel mondo. Le cose che sottovalutiamo molto spesso rappresentano grandi possibilità per il futuro di tutti. Solo se ognuno di noi fa la sua piccola parte si potrà ottenere un vero cambiamento».
Serena Lastoria