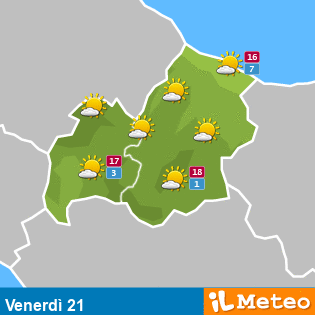Quel viaggio da Campobasso ad Avellino per tradurre il camorrista della Nuova camorra organizzata (NCO) Mario Cuomo doveva rimanere segreto. E invece qualcuno, dal penitenziario di via Cavour del capoluogo molisano, il 7 ottobre del 1982, ha fornito le informazioni che hanno permesso ad un commando di camorristi della NCO di liberare il loro giovanissimo affiliato detenuto per omicidio. Nove i banditi che a bordo di tre auto, parteciparono all’assalto. Uno dei tre carabinieri impegnati nel servizio venne ucciso. Cuomo si sarebbe dovuto presentare, una settimana dopo, il 14 ottobre, davanti alla sezione speciale del Tribunale di Avellino, con altri 21 presunti camorristi, per l’adozione di provvedimenti di polizia. Le indagini che avevano portato al processo nella città campane erano state coordinate dall’allora sostituto procuratore Antonio Gagliardi, ferito nell’attentato del 12 settembre dello stesso anno a Monteforte Irpino e che, quel 7 ottobre del 1982, era ancora ricoverato all’ospedale di Avellino. Probabilmente, come hanno scritto i giornali locali in quei giorni, la liberazione di Cuomo «aveva l’obiettivo di seminare il terrore in provincia alla vigilia del processo e della mobilitazione dei consigli comunali convocati in tutti i 119 centri della provincia per domenica mattina».
Prima le indagini, poi il rinvio a giudizio delle persone sospettate di aver partecipato all’uccisione del Di Mella e l’unificazione di diversi fascicoli perché per gli inquirenti quel gruppo di fuoco era lo stesso che si era reso responsabile di altri omicidi.
Per la traduzione di Cuomo ad Avellino, si è sempre parlato dell’utilizzo di un blindato. In realtà si trattava di una Peugeot 505 guidata da un civile. Di Mella, quel viaggio non lo doveva fare essendo stato in servizio la sera precedente per un altro trasferimento. Lo avevano chiamato dalla caserma chiedendogli un ulteriore sforzo e lui non aveva saputo dire di no.
A Di Mella, così come per tante altre vittime delle forze dell’ordine, è arrivata successivamente la medaglia al valor civile. Un riconoscimento postumo che lo Stato riserva a chi perde la vita nell’esercizio delle sue funzioni e che tende anche a recuperare un rapporto tra istituzioni e famiglie spesso conflittuale. Il carabiniere è rimasto in servizio in Molise praticamente fino al pomeriggio del 7 ottobre dell’82, quando l’auto sulla quale viaggiava quel giorno, all’altezza dell’uscita del casello di Avellino Est sull’autostrada Napoli-Bari, è stata assaltata. Un colpo di pistola viene esploso nella parte posteriore dell’auto dove siede Di Mella accanto al detenuto in catene. Minacciato non si arrende. Il carabiniere viene prima colpito con il calcio dell’arma alla testa e poi ucciso con un colpo di pistola. Un lutto per l’Arma dei Carabinieri. Una tragedia per la famiglia, la moglie e il figlio di tre anni.
 Durante la sua permanenza nei Carabinieri, Di Mella aveva prestato servizio a Ripabottoni, Vinchiaturo e infine a Campobasso. Nella motivazione del conferimento della Medaglia d’oro al valore c’è scritto: «Durante il servizio di traduzione di un pericoloso esponente della criminalità organizzata, con ferma determinazione ed eccezionale senso di abnegazione affrontava l’assalto di otto malviventi armati volto a liberare il pregiudicato e, nello strenuo tentativo di impedirne la fuga, veniva mortalmente colpito nella sparatoria. Mirabile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio».
Durante la sua permanenza nei Carabinieri, Di Mella aveva prestato servizio a Ripabottoni, Vinchiaturo e infine a Campobasso. Nella motivazione del conferimento della Medaglia d’oro al valore c’è scritto: «Durante il servizio di traduzione di un pericoloso esponente della criminalità organizzata, con ferma determinazione ed eccezionale senso di abnegazione affrontava l’assalto di otto malviventi armati volto a liberare il pregiudicato e, nello strenuo tentativo di impedirne la fuga, veniva mortalmente colpito nella sparatoria. Mirabile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio».
L’assalto permette a Mario Cuomo di fuggire ma viene arrestato nuovamente il 29 gennaio del 1983. Uscito dal carcere, l’11 ottobre del 1990, il camorrista viene ucciso in un agguato a Napoli in seguito all’esplosione dall’auto sulla quale si è appena messo alla guida. L’esecutore materiale dell’uccisione di Di Mella, Luigi Maiolino, confessa l’omicidio e inizia a collaborare con la giustizia fornendo informazioni su altri delitti di camorra.
Della traduzione di Mario Cuomo dal carcere di Campobasso all’aula di giustizia di un’altra città, quel giorno, non sapeva nulla nessuno, tranne chi, per le sue funzioni, si occupa di organizzare questo servizio. Se parla è la fine di ogni riservatezza, specie se le informazioni in suo possesso le mette a disposizione di un gruppo criminale come quello della famiglia Cutolo. Il nome del responsabile di questa soffiata i poliziotti dello Sco lo sapranno solo 12 anni dopo, tra la fine del 1994 e l’inizio del 1995 quando, indagando su un traffico di droga organizzato e diretto da un esponente di spicco della Sacra Corona Unita ospite del penitenziario di via Cavour a Campobasso, un collaboratore di giustizia fornisce le informazioni in suo possesso su quell’episodio.
Gli uomini dati per appartenenti alla NCO, che sta per Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, ospitati nel carcere di Campobasso, sono stati sempre tantissimi anche agli inizi degli anni Ottanta. Il penitenziaro è una comunità complessa da gestire e può succedere di tutto: minacce, ferimenti, diffamazioni, contrasti e non mancano gli omicidi. È il primo ottobre dell’81 quando i commercianti di via Cavour e corso Bucci vedono un’ambulanza stazionare nel piccolo piazzale che divide il cancello di ferro off limits e il portone di legno interno del carcere. Un rituale quando c’è un detenuto che sta male e deve essere accompagnato in ospedale. Quella mattina però il mezzo di soccorso resta fermo lì per parecchio tempo. Nel frattempo varcano il cancello il magistrato di turno e alcuni uomini delle forze dell’ordine. Qualche ora dopo si saprà che un detenuto, Franco Diana, è stato ucciso, colpito per 33 volte con la lama di un coltello. Sotto processo finiscono Ciro Nocerino, indicato come intermediario del delitto dal pentito Pasquale Barra, e il capo della NCO Raffaele Cutolo accusato di essere il mandante. Per l’accusa, gli esecutori materiali sono Michele Mangiapia, Salvatore Velotto e Salvatore Imperatrice. Nell’83 e nell’84, il processo in Corte d’Appello a Campobasso. Due le udienze. I giudici condannano i tre uomini ritenuti esecutori materiali dell’omicidio a 22 anni di reclusione e assolvono, per insufficienza di prove, Ciro Nocerino. Con la stessa motivazione la Corte assolve anche Raffaele Cutolo. Ed è proprio l’assoluzione di Cutolo a compromettere definitivamente la credibilità del super pentito Pasquale Barra, ex luogotenente del capo della NCO e grande accusatore di Enzo Tortora, visto che è proprio Barra, dopo essersi pentito, a riferire ai giudici di Foggia che il mandante dell’omicidio di Franco Diana nel carcere di Campobasso è il suo ex boss. La sentenza di primo grado viene confermata dalla Corte d’Assise d’Appello nell’ottobre del 1985. Un’ora di camera di consiglio e alcuni particolari in più sull’omicidio in carcere. «Diana – dice il procuratore nella sua ricostruzione dei fatti – viene costretto ad entrare nella cella dei killer del boss e ucciso con 33 coltellate dagli imputati». Uno di questi, Salvatore Imperatrice, successivamente si impicca in una cella del penitenziario.
Quello di Campobasso, dicono le cronache di quegli anni, è il primo dibattimento imperniato sulle dichiarazioni dei pentiti e in particolare di Pasquale Barra che fa il suo esordio come superteste in un’aula di giustizia. La data, il 19 novembre dell’83. Il faccia a faccia con Cutolo, che con il sorriso sulle labbra minaccia di morte l’ex figlioccio, si ha proprio nel processo di Campobasso. Il giudice Donato Del Mese, che non accoglie la richiesta di ergastolo avanzata dal pubblico ministero Pier Luigi Laviani, nella sentenza scrive in modo chiaro e inequivocabile che «Barra è teste inattendibile, lacunoso e contraddittorio». Raffaele Cutolo muore il 17 febbraio 2021 dopo una lunga malattia in una stanza dell’ospedale di Parma.
Il “professore”, cioè Cutolo, ha passato 55 anni in prigione e, di questi, 38 di carcere duro. In vita, il capo della NCO si sente importante. Il suo vanto maggiore, l’amicizia con potenti e politici che a lui spesso si rivolgono come quando chiedono la mediazione per la liberazione dell’assessore regionale campano Ciro Cirillo rapito dalle Brigate Rosse. Un grande errore perché quando lo Stato chiede aiuto ad un camorrista di questo spessore criminale riconosce di aver fallito nel suo ruolo di garante della legalità. Gli atti processuali dicono infatti che Raffaele Cutolo, per tutta la sua vita, si è reso responsabile di una spietata guerra di camorra con 1.500 vittime.
camorrista di questo spessore criminale riconosce di aver fallito nel suo ruolo di garante della legalità. Gli atti processuali dicono infatti che Raffaele Cutolo, per tutta la sua vita, si è reso responsabile di una spietata guerra di camorra con 1.500 vittime.
Non si è mai pentito, il capo della Nuova camorra organizzata. Chi capisce tutto e subito è il Presidente della Repubblica Sandro Pertini che nel 1982 pensa, ed esterna il suo pensiero, affermando che «il posto migliore dove spedire Cutolo è il carcere dell’Asinara». Ci sono detenuti di ogni tipo e spessore criminale nei penitenziari del Molise. Tra questi anche Giovanni Melluso chiamato «Gianni il bello o cha cha cha». Personaggio eccentrico, Melluso. Anche lui come Pasquale Barra e Giovanni Pandico accusa Enzo Tortora di traffico di droga. Una montagna di bugie per incastrare uno dei presentatori più popolari della televisione italiana. Uscito dal carcere, Giovanni Melluso dice di volersi mettersi in ginocchio per ciò che ha fatto nei confronti di Tortora. La dichiarazione appare come un’altra delle sue trovate per guadagnare la scena così come fa ogni volta che prova a sfruttare la sua posizione di pentito. È marzo del 1986 quando Melluso invia al ministro di Grazia e Giustizia Mino Martinazzoli e al direttore degli Istituti di Prevenzione e Pena, un telegramma che viene reso pubblico dalla sua compagna di vita. «Mia moglie – scrive “Gianni il bello” – mi ha informato che un giornalista del settimanale “Oggi”, reduce da un convegno a Torino, le ha detto che pentiti di altri penitenziari hanno rapporti intimi con mogli, fidanzate e visitatrici varie. Desidero conoscere per quali motivi, io non posso avere – dice nel telegramma – uguali rapporti con la mia legittima consorte. Forse Pannella lo ha vietato?». In realtà l’uscita di Melluso sembra essere un modo per fare pubblicità al suo libro “Gianni il bello, autobiografia di un pentito”.
Giovanni Mancinone