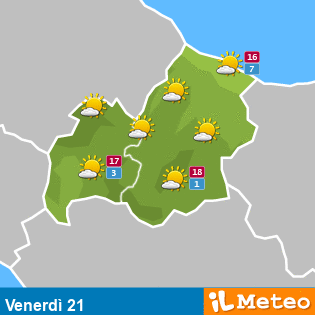Ogni anno, nel cuore di Campobasso, si ripete una tradizione che emoziona e coinvolge migliaia di persone: parliamo della processione del Venerdì Santo, accompagnata dal suggestivo canto del coro. Un momento di intensa partecipazione e spiritualità. A dirigere da 13 anni questa straordinaria compagine di circa 700 voci è il Maestro Antonio Colasurdo, custode di un’eredità musicale che si tramanda da generazioni.
In questa intervista, il Maestro ci racconta i segreti dell’armonia che unisce le voci e le anime dei cantori, il significato profondo di questa tradizione e le storie che si intrecciano tra le fila del coro, dove spesso si ritrovano intere famiglie a tramandare il proprio amore per questo evento. Parleremo anche di curiosità, come l’origine degli impermeabili indossati dai cantori, e del celebre Teco Vorrei, musicato dal Maestro De Nigris, che risuona con una forza emotiva unica per le strade del capoluogo.
Ma soprattutto, cercheremo di capire perché, dopo secoli, questa tradizione riesca ancora a toccare così profondamente il cuore di un’intera città.
Maestro, lei dirige il coro del Venerdì Santo dal 2012 dopo aver raccolto l’eredità di don Armando Di Fabio. Ricorda il momento in cui le è stato affidato questo incarico? Come ha accolto la proposta?
«In realtà non c’è stato un incarico ufficiale. Il passaggio è avvenuto in modo ‘naturale’. Ricordo che, durante una delle ultime prove in Cattedrale per il coro del Venerdì Santo, don Armando disse testualmente: “Il maestro Colasurdo mi sostituirà in tutto”.
All’epoca non compresi fino in fondo il significato di quelle parole, ma col tempo ho capito che quel “in tutto” si riferiva non solo al coro del Venerdì Santo, ma anche al Settenario, alla Corale Trinitas e a tutte le attività musicali che lui seguiva.
La sua indicazione è stata accolta con favore anche da don Michele Tartaglia, parroco della Cattedrale, il cui parere era fondamentale».
Coordinare oltre 700 voci non sembra un compito semplice. Come si fa a creare armonia tra così tante persone?
«Oggettivamente non è semplice. L’armonia nasce dal rispetto reciproco tra i membri del coro e dal rapporto di fiducia che si costruisce con il direttore. Quando c’è fiducia, si crea un clima sereno e collaborativo, e l’armonia può nascere anche al di là delle singole capacità vocali».
Molti cantori portano avanti una tradizione familiare che si tramanda di generazione in generazione. Allo stesso tempo, sono in tanti a desiderare di far parte del coro. Come avviene la selezione dei nuovi membri?
«C’è sicuramente un aspetto di familiarità, ma non è detto che, se canta il padre, automaticamente anche il figlio entri a far parte del coro. Mi capita spesso di trovarmi in situazioni simili, ma cerco di non assecondare questa logica, perché il ricambio generazionale è importante, sì, ma non deve avvenire per forza all’interno della stessa famiglia.
La “selezione” non è una vera e propria audizione tecnica. Quando valuto chi può entrare nel coro, non considero solo le doti vocali o la preparazione musicale. Ci sono molti elementi che concorrono. Uno di questi è il confronto con i sacerdoti della Cattedrale, perché il coro non è “mio”, ma è di tutti. Non si tratta di una gestione personale o unilaterale. E in ogni scelta cerco sempre di agire con molta attenzione e delicatezza».
Negli anni ha notato una maggiore partecipazione da parte dei giovani?
«Sì, c’è sicuramente una maggiore partecipazione ma coinvolge tutte le fasce d’età. Ricevo richieste sia da giovani che da persone più adulte. Al momento, ci sono circa 150 persone in attesa di entrare nel coro. Quindi l’interesse è reale e costante: quasi ogni giorno qualcuno mi ferma per dirmi che vorrebbe farne parte. Probabilmente, il lavoro portato avanti in tutti questi anni ha contribuito a generare questo entusiasmo e desiderio di partecipazione».
In questi giorni è impegnato con il Settenario dell’Addolorata e con il canto dello “Zuchetazù”, un termine che viene spesso definito onomatopeico perché richiamerebbe il dialogo tra violini e contrabbassi nell’inno Oh, di Gerico Beata del maestro De Nigris. Lei è d’accordo con questa definizione?
 «Definire Zuchetazù un’onomatopea è un errore che sento fare spesso. Sui social, in particolare, circolano versioni fantasiose e completamente sbagliate di questo termine. C’è chi lo storpia, chi lo interpreta come un semplice “botta e risposta”. Ma come si può dire che Zuchetazù sia un botta e risposta?
«Definire Zuchetazù un’onomatopea è un errore che sento fare spesso. Sui social, in particolare, circolano versioni fantasiose e completamente sbagliate di questo termine. C’è chi lo storpia, chi lo interpreta come un semplice “botta e risposta”. Ma come si può dire che Zuchetazù sia un botta e risposta?
Zuchetazù è un termine che ha un tono canzonatorio, e non rende minimamente giustizia a ciò che rappresenta. È come se stessi recitando l’Ave Maria: parliamo infatti di una composizione di preghiera, una preghiera cantata, che non può essere identificata con una definizione del genere, anche se con le migliori intenzioni.
Se, ad esempio, volessimo promuovere il periodo quaresimale a Campobasso e dicessimo che si tiene lo Zuchetazù, cosa penserebbe un turista? Probabilmente immaginerebbe qualcosa di folkloristico, persino carnevalesco. E come si può spiegare, solo attraverso quella parola, che si tratta invece di un momento profondamente serio e spirituale?
Quello che cerco di fare è difendere la dignità e la serietà di questa tradizione. Capisco che nel dialetto popolare il termine possa circolare, ma utilizzarlo in ambito ufficiale o promozionale, a mio avviso, sarebbe un’assurdità».
Il maestro De Nigris è anche l’autore della musica del celebre Teco Vorrei. Cosa, secondo lei, rende questa melodia così potente e commovente?
«Questa melodia è ormai entrata a far parte della tradizione popolare. Le persone la ascoltano e la cantano con l’anima, perché riesce a toccare corde profonde. È lo stesso effetto che si prova ascoltando l’Aria sulla quarta corda di Bach o la Sinfonia n. 40 di Mozart. Sono melodie che arrivano dritte al cuore perché è nella loro semplicità che risiede la loro forza. Ed è proprio questa semplicità la chiave del loro successo: parlano a tutti, senza bisogno di spiegazioni».
Una domanda che molti si pongono: come nasce la tradizione degli impermeabili indossati dai cantori? C’è sempre stata o è subentrata in un secondo momento?
«Non c’è sempre stata. Ci sono foto che mostrano come un tempo ciascuno partecipasse all’evento con l’abbigliamento che preferiva. Negli anni ‘80, però, don Armando ha cercato di dare un po’ di uniformità al coro. Gli impermeabili per gli uomini furono donati dai Carabinieri dell’epoca: rimasero circa 300-400 impermeabili inutilizzati, che vennero così distribuiti agli uomini del coro. Tant’è che oggi questi impermeabili sono introvabili; chi ce l’ha lo passa ad altri. Qualcuno ha provato ad acquistarli, ma non si trovano più.
Questo è uno dei motivi per cui il coro non può crescere a dismisura: senza impermeabili, non ci sarebbe più uniformità. Certo, ogni tanto ci si arrangia, ma non è la stessa cosa. Per cercare di uniformare anche il coro delle donne, è stato scelto invece un impermeabile blu, che però è più facilmente reperibile.
In ogni caso, questa è una scelta che ho trovato e della quale non posso assumermi la paternità».
C’è un aneddoto, una curiosità particolare legata alla processione che le è rimasta impressa e che vuole condividere con i nostri lettori?
«Ce ne sono talmente tanti che al momento non saprei quale scegliere. Certo è che ce ne sono di simpatici, ma anche altri che lo sono un po’ meno».
Questa tradizione appartiene a Campobasso, ma cosa dice – secondo lei – dell’anima più profonda di questa città?
«Dice tutto. La tradizione si basa sulla collaborazione e partecipazione di tutta la comunità, attraverso una selezione di voci. Nel coro sono rappresentati tutti i ceti sociali della città: dall’avvocato al falegname, dalla casalinga al disoccupato. È davvero lo specchio della città, perché ogni settore è rappresentato. In questo modo, possiamo dire che il popolo stesso canta attraverso i cantori».
Infine maestro, se dovesse descrivere con una sola parola ciò che rappresenta per lei la processione del Venerdì Santo, quale sceglierebbe? E perché?
«Ne uso due: onore e onere. È un onore perché è una bellissima responsabilità e credo che chiunque vorrebbe essere al mio posto. E un onere perché, finché c’era don Armando, non ero mai stato coinvolto direttamente nel Venerdì Santo, se non per la preparazione precedente. Il Venerdì Santo era, infatti, l’unico giorno libero per me, quando ero organista in Cattedrale. Da quando dirigo il coro, invece, è diventato l’unico giorno che mi impegna e mi assorbe completamente durante tutto l’anno».
Serena Lastoria
Nella foto il maestro Antonio Colasurdo (per gentile concessione del fotografo Lorenzo Albanese)